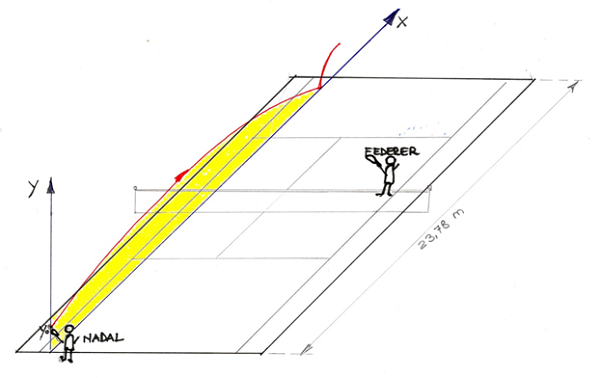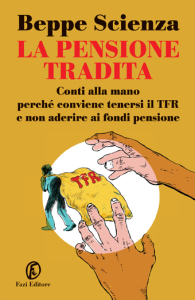Programma del 47° Congresso Unione Astrofili Italiani – Castiglione dei Pepoli 9 – 11 Maggio 2014. Programma e abstract degli interventi.
15:00 Apertura segreteria Congresso e Benvenuto del LOC
15:30-17:05 Sessione Astrocultura e Didattica Chairman: Sandro Bardelli (INAF-OABo)
15:30 Relazione introduttiva del chairman
15:50 L’equazione che Newton non scrisse. Francesco Castaldi
The following pages are in connection with what the author explained during the UAI Congress of La Spezia, 2005: Newton never wrote the known formula for the gravitational force between two masses, but expressed his certitude that this force was proportional to the inverse square of their distance. As to other opinions he simply wrote: «hypotheses non fingo». Now, the author has followed the historical development of the question arriving at the conclusion that this formula represents an “expedient mathematical abridgement” of two fundamental Newton’s statements. On the other hand, as to applications of physics, it’s important to verify, about the end of XVIII and the following century, that every progress in calculations (Lagrange, Laplace, Gauss and so on) went on ignoring any reference to this formula.
16:05 A scuola di tempo: il potere educativo delle meridiane. Antonina Speziale
Il cielo era il luogo della sapienza. I nostri antenati usavano il cielo come specchio della Terra, come carta geografica, come orologio, come calendario. Con la mitologia e i fantastici nomi che usavano assegnare alle stelle proiettavano nel cielo i loro desideri , le aspettative , gli inganni, i conflitti e non smettevano di contemplarlo anche per il solo fascino di coglierne tutta la grande bellezza. Le attività educative e didattiche che, come astrofili, svolgiamo sulle meridiane servono a riportare gli occhi al cielo, ma paradossalmente puntando lo sguardo per terra per scoprire cosa una meridiana è in grado di fare e come padroneggiare precise conoscenze astronomiche.
16:20 Dove i telescopi ancora non vedono. Angelo Adamo
L’illustrazione scientifica, grazie alla visionarietà di grandi artisti sensibili al fascino della ricerca astronomica e astronautica, ci ha consentito di farci un’idea precisa dei possibili scenari che ci troveremo un giorno a osservare da altri luoghi nel cosmo diversi dal nostro pianeta. In questo talk vorrei rendere omaggio ad alcuni di questi geni al servizio della scienza per mettere in evidenza le implicazioni scientifiche, artistiche, politiche e sociali derivanti dal sapiente impiego della space-art.
16:35 Mappa della Galassia a 1420 MHz. Mario Sandri
Il progetto didattico, condotto con alunni di scuola media superiore, ha come fine quello di andare ad indagare alcuni aspetti fondamentali della Via Lattea, la nostra Galassia. Per comprendere in profondità gli aspetti della stessa non ci si può semplicemente limitare ad osservarla con strumenti nel campo del visibile, ma è necessario utilizzare altre tecniche proprie di quella branca dell’astronomia che prende il nome di radioastronomia. Per questa ragione è stato utilizzato un radiotelescopio dell’Onsala Space Observatory presso la Chalmers University of Technology in Svezia, comandato da remoto, cioè stando comodamente seduti da casa. Attraverso una webcam è stato possibile addirittura vederne i movimenti in tempo reale. Tramite questo strumento è stata indagata la presenza d’idrogeno nella Galassia. L’idrogeno, in particolari condizioni e naturalmente, emette un’onda elettromagnetica che è facilmente catturabile da questo tipo di strumento. I dati acquisiti in molte ore di osservazione sono serviti per ottenere dei risultati scientifici apprezzabili. In particolare è stata ricavata la cosiddetta curva di rotazione della Galassia, la cui caratteristica principale è quella di evidenziare la presenza di materia oscura, cioè di materia che non emette radiazione luminosa, come, ad esempio, possono essere pianeti o asteroidi. Inoltre è stato possibile disegnare un grafico della struttura della Galassia e questa appare, come nell’immaginario comune, avente una struttura spiraleggiante. Infine è stata “pesata” la Galassia stessa entro i limiti dell’orbita del Sole.
16:50 Archeoastronomia dei misteri e degli inganni – Discorso sulla fondazione epistemologica dell’archeoastronomia. Paolo Colon
L’Archeoastronomia, scienza giovane e interdisciplinare, manca di una fondazione epistemologica, e le sue indagini dipendono dalle competenze e intuizioni personali di ricercatori con preparazioni e storie assai differenti. Una raccolta di clamorose sviste recentemente diffuse, anche ad alti livelli, nel campo archeoastronomico contribuirà a elencare e classificare gli errori in cui rischia di incappare il ricercatore privo di un saldo criterio di ricerca. Da questa indagine emergono linee guida per un metodo che dovrebbe diventare bagaglio standard di ogni studioso che si cimenta nella ricerca archeoastronomica.
17:05 Coffee break
17:20-18:25 Sessione Divulgazione Chairman: Marco Morelli (Museo Scienze Planetarie di Prato)
17:20 Relazione introduttiva del chairman
17:40 I nostri primi quindici anni. Massimo Elmi, Stefano Fabbri, Michele T. Mazzucato, Marco Valentini.
Breve storia del Gruppo M1 nei suoi primi quindici anni. Punto di riferimento dell’Alto Appennino bolognese per la divulgazione delle scienze astronomiche. Opera con semplicità e passione in un ambiente ancora sufficientemente scevro dall’invadente inquinamento luminoso. L’incontro con la gente permette di trasmettere questa passione e con la speranza che per qualcuno veramente interessato possa essere un trampolino di lancio per i più alti intenti.
17:55 Progetto di un atlante astronomico Salentino. Ferdinando De Micco.
L’attività progettuale, svolta nel periodo Dicembre 2012- Aprile 2014, è stata quella di avvicinare il grande pubblico alle bellezze dell’Universo attraverso un parallelismo tra spazio vissuto e spazio visivo, per mezzo di attività senso-percettive. Per fare ciò sono stati individuati due ” grandi attrattori culturali ”: Palazzo-Museo Faggiano, sito nel cuore del centro storico di Lecce e il complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia in Taranto sito a pochi passi dai grandi complessi industriali (ILVA, ENI) della città. La peculiarità di entrambe le iniziative è rappresentata dal parallelismo tra il racconto della storia degli edifici (continuum storico ) e le osservazioni astronomiche contestuali ai luoghi ( continuum spazio-visuale ). Si propone di replicare tale attività in luoghi-contenitori diversi presenti nel nostro Paese in modo da trasformarla in evento per nostro Calendario Nazionale.
18:10 Raccontare e insegnare il cielo e le stelle: fare il punto per ripartire. Angelo Adamo e Sandro Bardelli
In questo nostro intervento riassumeremo i risultati di un workshop che, insieme ad altri colleghi, abbiamo organizzato di recente (25-26 Marzo 2014). Patrocinato da vari enti tra i quali anche la Fiera del Libro per Ragazzi che ci ha ospitato in uno dei suoi padiglioni, la peculiarità dell’incontro è stata l’aver costituito un’occasione per far finalmente dialogare astronomi, divulgatori, insegnanti, pedagoghi, psicologi dell’età evolutiva e altri operatori del settore sui temi della didattica e della divulgazione dell’astronomia per bambini dai 2 ai 12 anni. L’incontro è stato un successo e ha messo in evidenza aspetti molto interessanti che riteniamo valga la pena condividere con il pubblico dell’UAI.
18:25 18:30-20:00 Lectio Magistralis pubblica – Prof. Giampaolo Vettolani
20:30-21:30 Cena 21:30 Star party pubblico – Notte stellata UAI
Sabato 10 Maggio 2014
09:30 Apertura segreteria Congresso
10:00-13:00 Sessione Sistema Solare Chairman: John Brucato (INAF-OA Arcetri)
10:00 Relazione introduttiva del chairman
10:20 La missione NASA – LADEE e la ricerca degli Impatti Lunari. Antonio Mercatali.
La Sezione di Ricerca Luna ha collaborato nei ultimi mesi del 2013 e nei primi mesi del 2014 con la NASA per la missione LADEE, acronimo di Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer. Questa collaborazione è nata quando nel mese di Giugno 2013 l’ente spaziale americano ha contattato la Sezione di Ricerca Luna UAI con la richiesta di collaborazione specifica per la ricerca degli impatti lunari, un programma di alta valenza scientifica coordinato a livello mondiale dal Marshall Space Flight Center e che ha lo scopo di osservare, registrare e monitorare la quantità di meteoroidi provenienti dallo spazio esterno che periodicamente cadono a forte velocità sulla superficie lunare, e che al momento dell’impatto trasformano una quantità in percentuale molto alta della propria energia cinetica posseduta in luce bianca visibile simile ad un rapido flash che può essere osservato dalla Terra con telescopi anche non professionali e sui quali vengono installate delle videocamere per astronomia di ultima generazione.
10:40 Il 2013 nel massimo del ciclo XXIV. Luciano Piovan
Con il massimo di dicembre del NW (110) e l’inversione della forte attività all’emisfero sud nel mese di giugno, il sole sembra abbia raggiunto il suo periodo massimo del ciclo undecennale XXIV con un’intensità media del valore R di 82.3 paragonabile ai cicli solari di inizio del secolo scorso. Inoltre, questo ciclo solare conferma la prosecuzione della diminuzione dei massimi dopo il ciclo XIX, in cui è avvenuto il massimo più alto da quando Galileo iniziò l’ osservazione del sole (XIV secolo).
11:00 L’evoluzione fotometrica delle comete “nuove” e la loro possibilità di sopravvivenza a passaggi radenti al Sole: i casi delle comete C/1973 E1 (Kohoutek) e C/2012 S1 (ISON). Giannantonio Milani.
La recente apparizione della cometa C/2012 S1 (ISON) ha riportato in primo piano alcune problematiche relative alle comete che per la prima volta si avvicinano al Sole. Viene effettuata una breva panoramica sul comportamento fotometrico delle comete “nuove” e delle possibilità di sopravvivenza di una cometa in caso di distanze perieliche molto piccole. Come esempio di differente evoluzione e destino vengono poste a confronto le comete C/1973 E1 (Kohoutek) e C/2012 S1 (ISON).
11:20 Stardust mission & Stardust@home project. Michele T. Mazzucato.
Breve cenno introduttivo della missione Stardust (1999-2006) e descrizione del progetto Stardust@home per la ricerca della polvere interstellare. Un duro lavoro di analisi attraverso il microscopio virtuale cui partecipano migliaia di volontari da tutte le parti del mondo. Il contributo italiano in questa avventura.
11:40 Asteroidi per astrofili. Paolo Bacci
Gli astrofili possono dare un contributo scientifico rilevante nello studio degli asteroidi. Oltre alla ricerca di nuovi asteroidi, possono cimentarsi ad effettuare il Follow-Up, la recovery, curve di luce al fine di determinare il periodo di rotazione, nonché ad individuare altre caratteristiche morfologiche.
12:00 Riflessioni sull’osservazione delle meteore. Enrico Stomeo.
I dati che concernono le meteore, derivanti sia da osservazioni visuali, che fotografiche o video, possono facilmente presentare delle carenze e imprecisioni nelle informazioni, che rendono inattendibile qualsiasi risultato. Solamente un’attenta valutazione critica degli stessi e una eventuale successiva loro revisione può assicurare la loro completezza.
12:20 RZHR: Analisi di sciami meteorici da dati RAMBO. Gaetano Brando e Plumari Matias
RAMBO, radar meteorico dell’Associazione Astrofili Bolognesi attivo dal 2013, ha raccolto una quantità di dati elevata: tale mole di informazioni è analizzata da RZHR, programma software progettato per essere un pacchetto completo. Tale programma calcola l’RZHR, un valore simile al tasso orario zenitale da noi elaborato. Dopo aver introdotto il software e mostrato il processo di elaborazione dati, illustreremo due importanti risultati su altrettanti sciami meteorici del 2013.
12:40 Studio delle Geminidi 2013. Mario Sandri
Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare uno sciame meteorico attraverso la posizione del massimo di attività. Nell’analisi abbiamo studiato il comportamento delle Geminidi, sciame attivo verso la metà del mese di dicembre che presenta un’origine asteroidale. Il suo corpo progenitore è l’asteroide 3200 Phaethon. I dati ci sono stati forniti dall’Associazione Astrofili Bolognesi che ha costruito un apparato radio in grado di registrare gli echi meteorici. La tecnica da loro sfruttata si basa sul principio del forward-scatter. Per poter analizzare i loro dati è stato necessario costruire un programma in linguaggio C. L’analisi dei dati si è basata su una tecnica di indagine che prevedeva la correzione di due importanti fattori: la sottrazione del background sporadico e l’altezza del radiante sopra l’orizzonte. I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli forniti dal Radio Meteor Orservating Bulletin che studia l’attività meteorica attraverso tecniche radio. Successivamente si è studiato il comportamento dello sciame analizzando i dati visuali prelevati dall’archivio dell’International Meteor Organization. I nostri risultati sono stati confrontati con un’analisi preliminare svolta dalla stessa organizzazione. Infine sono stati comparati i risultati ottenuti con le due tecniche. Le conclusioni a cui siamo giunti sono inoltre state confrontate coi dati offerti dalla letteratura scientifica. Abbiamo evidenziato, in particolare, come lo sciame meteorico delle Geminidi faccia parte di un complesso meteorico più vasto dove sembra esserci la presenza di due sciami con caratteristiche simili.
13:00 Pausa pranzo
14:30-17:00 Assemblea dei Soci UAI Nell’ambito dell’ordine del giorno, sono previste specifiche sessioni di discussione su: Associazionismo Astrofilo Attività delle Sezioni di Ricerca Attività delle Commissioni
17:00-17:30 Coffee break
17:30-18:00 Premiazioni: Premio Falorni, Premio Ruggeri, Premio Astroiniziative, Premio “Stella al Merito”
18:00-20:00 Premio Lacchini e Lectio Magistralis del premiato
20:30 Cena Sociale
Domenica 11 Maggio 2014
09:30 Apertura segreteria Congresso
09:30-10:30 Sessione Inquinamento Luminoso Chairman: Alessandro Battistini (Hera Luce)
09:30 Relazione introduttiva del chairman
10:00 Il sito web di LazioStellato. Mario Di Sora
10:15 Dibattito
10:30-11:20 Sessione Strumentazione, Astrofotografia e Tecnica Chairman: Emiliano Diolaiti (INAF-OABo)
10:30 Relazione introduttiva del chairman
10:50 Il progetto RAMBO. Barbieri Lorenzo e Cifiello Daniele
RAMBO (Radar Astrofilo Meteorico BOlognese) è il radar meteorico costruito dall’Associazione Astrofili Bolognesi con lo scopo di captare automaticamente le meteore e registrarne le caratteristiche. Dopo aver introdotto il progetto e le sue attuali capacità, illustreremo quali saranno gli sviluppi futuri dello stesso RAMBO e mostreremo alcuni possibili risultati ottenuti nello studio degli space debris.
11:05 Astrofotografia sotto cieli inquinati – sviluppo di riprese in banda stretta. Giovanni Todesca.
Ormai i cieli sono sempre più soggetti all’inquinamento luminoso delle città, ma è ancora possibile proprio per chi vive in città o nelle periferie riuscire a fare astrofotografia? Fortunatamente si. Grazie al progredire dei mezzi tecnologici e alle tecniche di ripresa e post processing digitale, è possibile utilizzare filtri interferenziali capaci di isolare determinate lunghezze d’onda dannose, filtrando invece le emissioni delle nebulose e delle galassie. Questo processo ci regala immagini dai colori suggestivi e impensabili fino a pochi anni fa.
11:20-12:20 Sessione Astronomia Galattica ed Extragalattica Chairman: Francesco Ferraro (Dip. di Astronomia, Università di Bologna)
11:20 Relazione introduttiva del chairman
11:40 Osservazioni spettroscopiche amatoriali della Nova Delphini 2013 e della SN 2014 J nella galassia M82. Fulvio Mete.
Nova Delphini 2013 and Sn 2014 J were the two main events of the autumn 2013 and the winter 2014. This work is a small contribution to the spectroscopic observations of these events from the point of view of italian amateur astronomers, obtained by simple means.
12:00 Il programma di ricerca Detex della sezione pianeti extrasolari. Claudio Lopresti.
Nella sezione di ricerca UAI “Pianeti Extrasolari” esiste un programma di ricerca dedicato al miglioramento dei dati relativi ai pianeti extrasolari già conosciuti, che può essere considerato anche come potenziale strumento per trovare altri pianeti ancora sconosciuti. Il programma è basato sulla determinazione fine dell’epoca dei transiti di alcuni pianeti extrasolari che hanno mostrato anomalie e derive temporali. Analizzando i dati previsionali dei tempi di transito, e confrontandoli con i nostri dati osservativi, potrebbe essere possibile determinare se sono errate le previsioni fatte, oppure se esiste una massa perturbante nei pressi del pianeta.
12:30-13:30 Rinfresco di commiato
14:00 Chiusura segreteria Congresso